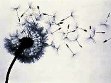
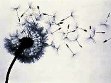
Vito Bianco – scrittore – poeta
Acqua agli assetati
Erano passate cinque settimane da quando la donna che da quattro anni viveva con me aveva deciso che ne aveva abbastanza e se ne era andata. Disse che sarebbe tornata domenica mattina – due giorni dopo – per prendere il resto delle sue cose: un certo numero di vestiti, due riproduzioni che aveva comprato l’anno prima al book shop del Prado e i tre grandi vasi che aveva sistemato agli angoli del soggiorno, azzurri e sottili, con i gigli finti che facevano capolino dalla bocca.
“Tu non farti trovare”aveva aggiunto. Aveva due grosse borse in mano, guardava per terra, i capelli le cadevano sugli occhi e io, a due passi da lei, notai che aveva messo il pullover al contrario, per distrazione, per ansia, per l’urgenza di finirla; forse anche perché temeva che il coraggio potesse venirle meno e fosse costretta a ricominciare tutto daccapo. Dissi che per me andava bene, che non c’erano problemi. Avrei voluto dire qualcos’altro ma non mi venne in mente nulla, solo una frase banale che certo non sarebbe servita a niente. Pensai che era meglio così.
Ero stordito; sapevo che poteva succedere e tante volte avevo immaginato la scena, ma adesso quella anticipazione mentale era diventata realtà ed era come se fosse andata via la luce e non ricordassi dove avevo messo le candele.
Lei alzò la testa e mi guardò. Il suo sguardo mi cadde addosso come acqua fredda. Trattenni il respiro e per un momento sperai di vederla cedere. Lei esitò. Forse aspettava che parlassi ancora. Invece feci i due passi che ci separavano e continuai verso la porta. Barbara si mosse e afferrò la maniglia prima di me.
Si era messa una delle due borse in spalla, i pesi la obbligavano a una postura innaturale. Aveva chiamato un taxi, che aspettava di sotto. Quando le porte dell’ascensore si richiusero sentii un vuoto alla bocca dello stomaco.
Qualcosa era andato storto. Si pensa sempre così, quando invece la verità è che semplicemente non c’è più quello che c’era all’inizio e per qualche tempo, o si credeva che ci fosse (in queste cose non c’è differenza tra la realtà e quello che si crede). Ora ero solo. Nella casa si installò un silenzio nuovo, persino il rumore delle macchine che correvano lungo il viale arrivava ora meno deciso. Erano le otto di sera e non sapevo che fare. Accesi il televisore e mi misi a guardare un telefilm che cominciava proprio in quel momento.
Vedevo le immagini ma non riuscivo a concentrarmi sulla storia, che si svolgeva per lo più dentro un ospedale. Si vedevano i feriti portati sulle lettighe, medici e infermiere con le facce scure e ansiose, dialoghi tra il caporeparto e una giovane paziente con l’aria afflitta in una stanza luminosa, una conversazione intima tra un medico cinquantenne e una collega più giovane, con i capelli rossi e gli occhi scuri e brillanti.
Ogni pochi minuti rivedevo Barbara con le borse in mano e l’aria smarrita e decisa allo stesso tempo, i capelli che le cadevano sulla bocca, l’esitazione, quella che mi era parsa un’esitazione. Dopo un po’ mi addormentai. Mi svegliai a notte fonda, per il freddo e i sogni agitati. Barbara non sarebbe tornata.
Dopo quella mattina ogni volta che entravo nel caffè la cercavo con lo sguardo e se non c’era ci restavo male. Restavo di cattivo umore per un bel pezzo, fino a quando, in sala professori o davanti alla macchina dell’espresso, Giorgio mi dava una pacca sulla schiena e mi chiedeva: “ Ma allora, si può sapere che hai? Pensi ancora a Barbara? “
“ Hai quasi indovinato; c’entra una donna; ma è un’altra “.
“ Bene. Le cose non possono che peggiorare “ concludeva con sentenzioso pessimismo, che era il suo modo di sdrammatizzare.
Quando c’era, quando la vedevo appoggiata al banco con le spalle all’ingresso, mi saliva dai piedi un gioia di adolescente di cui mi vergognavo, come se gli altri clienti potessero vedermela addosso come una maschera.
Allora facevo l’indifferente, fingevo di non averla vista, mi sedevo a leggere il giornale con la concentrazione di un filologo al lavoro su un testo raro. Lei si girava e mi chiamava, e io facevo la faccia sorpresa: “ E tu da dove salti fuori? “ Mi aveva detto subito che la sua ditta aveva trasferito gli uffici principali proprio in fondo a quella via. Dissi che era una fortuna, la mia scuola era a nemmeno duecento metri dal caffè e così potevamo vederci anche tutti i giorni, se ne aveva voglia. Lei scherzando aveva detto: “ Se è così, non prenderò nessun impegno. Dirò che sono impegnata con te ”.
Quegli incontri divennero una piacevole abitudine. Valeria aveva una bellezza discreta, che non dava nell’occhio e aveva bisogno di essere osservata con attenzione, e molti, anche dopo uno sguardo attento, non l’avrebbero trovata. Aveva un’allegria contagiosa, che all’inizio poteva sembrare frivolezza ma era invece una sorta di disciplina, di barriera della volontà alzata per difendersi da un passato di sofferenze che in certi casi può non passare mai.
Parlare con lei mi svuotava la testa, mi cancellava di colpo i pensieri scuri. Spesso ci davamo appuntamento per l’ora di pranzo e insieme, senza fretta, mangiavamo un panino o un’insalata, qualche volta gli spaghetti con le melanzane.
Verso la metà del mese le dissi che una di quelle sere potevamo andare al cinema, se ne aveva voglia e se poteva liberarsi. Ci avevo pensato molto prima di proporglielo: Valeria era una donna sposata, non potevo far finta di non saperlo. Lei fece un mezzo sorriso e disse: “ Ricordati che sono una donna sposata ”. Dissi che lo sapevo e che in effetti avevo fatto male a proporle il cinema. “ Non ho detto che non voglio venirci ” fece lei, seria.
Andammo al cinema; e dopo il cinema a cena in una trattoria. Intorno a mezzanotte la riaccompagnai alla macchina, che aveva lasciato poco lontano dalla sala. Mi chinai per salutarla nel momento in cui si girava dopo avere aperto la portiera dell’auto. Ci fu un secondo di incertezza, un mio equilibrio precario (avevo bevuto un paio di bicchieri di troppo), una sua improvvisa timidezza prima di un breve e irresoluto slancio di affettuosa riconoscenza per la serata che ci eravamo goduti. Finì che ci baciammo all’angolo delle bocche.
Nei giorni seguenti non si fece vedere. Ogni mattina speravo di vederla ma non c’era. Il venerdì, nell’ora di pausa tra una lezione e l’altra, mi aggirai per un po’ nei pressi del palazzo ottocentesco dove lavorava. Volevo e non volevo incontrarla; sentivo però che più passava il tempo e più difficile sarebbe stato ristabilire la confidenza che avevamo consolidato. In certi momenti perdevo la pazienza e quasi la maledivo per quella sparizione; in altri, all’opposto, la capivo, mi dicevo che aveva fatto bene a troncare un’abitudine che poteva diventare qualcos’altro. Lei ha un marito e un figlio, mi dicevo; sono io che non ho niente da perdere.
Ma poi tornavo con rinnovata ostinazione all’impazienza, alla voglia di vederla, di parlarle. Tornavo a sentire che mi stava facendo un torto, che non poteva scomparire così. Mi mancavano le sue risate, il gesto che faceva con la mano quando mi salutava da lontano, una mano piccola da bambina cresciuta. Anche questa se ne è andata, dicevo guardandomi allo specchio del bagno. Ma poi capivo che non poteva essere andata via una che non era mai davvero arrivata.
Poi un giorno tornò. E fu un ritornò che somiglia ad una apparizione. Era l’una. Finivo cinque ore estenuanti e mi avviavo a passi rapidi all’uscita. Lei era sull’altro lato della strada. Aveva un impermeabile azzurro e un ombrello bianco, di mezza misura, tenuto con la sinistra davanti al corpo, in un specie di posizione marziale, come se fosse pronta a respingere un attacco. Mi fermai e per un attimo mi vanne meno il respiro – lei aspettava senza fare un solo movimento; aspettava che attraversassi la strada per raggiungerla. A quell’ora c’era un gran via vai di macchine; non riuscivo a cogliere il momento giusto per passare, e non volevo correre.
Finalmente feci quei sessanta metri e la raggiunsi. Valeria mi guardò fisso; voleva sorridere ma quello che riusciva a fare era una smorfia, una specie di broncio infantile.
La presi per la mano e dissi: “ Andiamo. Qui c’è una gran confusione ”. Non voleva dire nulla, erano solo parole che evitavano il silenzio. Lei chinò una volta la testa per dire sì e ce ne andammo nella direzione del caffè, senza sapere bene cosa fare, la sua mano abbandonata e umida nella mia, la mia testa vuota come lo stomaco, un passo dietro l’altro, facendo attenzione a non far saltare la sintonia delle falcate, forse sperando entrambi che quella camminata si potesse farla durare all’infinito.
Arrivammo alla piazza che si apriva infondo alla via. Entrammo nel parco e dopo un giro lungo il perimetro ci sedemmo su una panchina. Valeria aveva ritirato la mano e l’aveva messa nella tasca dell’impermeabile; appoggiò l’ombrello sul bordo della panchina di legno verde consumato.
“ Dove sei stata? ”
“ In giro. Qua attorno. Credevo che mi avresti trovata. Ma forse non mi hai cercata. Non abbastanza, almeno ”.
Faceva la spiritosa, ma aveva la voce opaca e una luce debole negli occhi. Dissi che in effetti non l’avevo cercata per niente perché ero sicuro che prima o poi sarebbe riapparsa.
“Sapevo che volevi essere cercata, e per non darti soddisfazione non l’ho fatto”.
Mentre lo dicevo guardavo il suo profilo pallido e affilato, e mi venne voglia di toccarle le labbra con la punta delle dita. Per la prima volta sorrise. Si girò e sorrise. “Ma che bravo. Il signore è molto intelligente. Merita un premio“.
“Non sapevo che ci fosse un premio“ io dissi, e con una mano le accarezzai una spalla. Lei diede un’occhiata alla mano, che mi affrettai a togliere.
Poco dopo cominciò a piovere. Valeria aprì l’ombrello bianco e io mi accostai per ripararmi. Stavamo lì sotto, ascoltavamo le gocce sulla tela e non dicevamo niente. Intanto il parco s’era svuotato; eravamo soli; due figure vicine sedute su una panchina accanto a un platano sotto un ombrello bianco e sotto la pioggia che dopo un inizio blando era andata rapidamente aumentando e ora cadeva fitta sulla terra battuta del giardino, in alto un cielo compatto grigio scuro, quasi nero.
Passò un’ambulanza a sirene spiegate, sfiorando le auto che accostavano per farla passare; un bambino cinese nascosto chissà dove ci passò davanti correndo e sollevando spruzzi d’acqua all’intorno; da un balcone una madre gridava un nome. Valeria ebbe un brivido di freddo. Le cinsi le spalle e presi io l’ombrello, perché non si stancasse. Rimanemmo così per mezz’ora; a guardare la pioggia, a sentire il ritmo delle gocce contro la tesa dell’ombrello, a tremare. Ma dovevamo andare.
Si era tolta l’impermeabile e si era avvicinata alla finestra. Aveva una mano aperta dietro il collo. Vedevo il suo riflesso sul vetro.
“Quella è la chiesa di San Domenico, la riconosco“ disse senza voltarsi. Feci tre passi. Adesso ero dietro di lei, riuscivo a sentire l’odore del maglione e un altro, aspro, di un profumo che si era messa dietro le orecchie. Mi faceva male il petto. Un dolore intermittente, non forte ma amaro, come se un cibo avariato o mal digerito esalasse dalle viscere del corpo verso l’alto i suoi veleni non mortali ma nauseanti; in alto verso il cuore.
“Mi fa male il petto“ mi sentii dire, già pentito per aver detto una cosa così stonata e vagamente assurda. Valeria si voltò con una lentezza irreale e mentre diceva “ fammi sentire “ appoggiò la guancia sul mio sterno. Le misi una mano sui capelli biondo bruciato lunghi fino alle spalle e appena la toccai mi abbracciò stretto respirando con la bocca contro la lana del maglione. Sta cercando di darmi un po’ di fiato, mi venne da pensare. Oppure vuole fermare il dolore con il fiato tiepido del respiro.
“Si può fermare il dolore nel petto respirandoci sopra?“ chiesi guardando le gocce che scivolavano lungo il vetro.
“Certo che si può. Come fai a non saperlo?“
“E allora soffia“.
La spinsi verso il letto, e lei si sedette docile e remissiva. La spogliai con una fretta che non sapevo di avere. Fuori la pioggia era diventata un temporale, c’era uno strepito allegro e minaccioso di lampi e tuoni, a tratti si sentiva la voce sibilante e mutevole del vento. Si rifece vivo il dolore al petto ma decisi di non dargli importanza. Valeria si lasciava spogliare come una bambina, non collaborava e non opponeva resistenza. Alla fine rabbrividì e poi con le mani unite scese a coprirsi il ventre.
C’era poca luce, ma lo stesso riuscivo a vederla: una magrezza fragile, il viso teso, verticale, con la bocca larga, forse troppo larga, il naso sottile e un po’ arcuato, qual tanto che bastava a darle l’aria più adulta e decisa. Gli occhi erano grigio–azzurri, grandi, che facilmente si allargavano di meraviglia.
Ero sdraiato sul fianco accanto a lei, ancora mezzo vestito, senza più il maglione e la camicia ma con i pantaloni addosso, che lei ora cercava di aprire usando tutte e due le mani ma non sapendo bene dove metterle, tastando e riprovando, con una volontà di massaggio più che con la determinazione di portare a termine il compito che si era assegnata.
Le accarezzavo i seni piccoli ma duri, con i capezzoli rosa chiaro che si distinguevano netti nella penombra, due punti di luce che sembravano stare lì a rappresentare tutta l’intera fragilità della sua esistenza di carne, illuminando anche il suo respiro un po’ affannato che sapeva di pane appena sfornato. La cercai in mezzo alle gambe per vedere cosa avrei trovato, voglio dire, per costatare la condizione del suo desiderio, che al momento mi pareva incerto, più una mancanza di opposizione che una vera voglia. E in verità, se mi avesse detto di fermarmi non mi sarei stupito, e l’avrei subito accontentata, l’importante per me era di non riperderla, di sapere dove trovarla e di essere aspettato; era “ l’acqua “.
Invece la voglia c’era. In mezzo alle gambe era scivolosa ed elastica, con muscoli delle cosce sottili tesi e pronti alla scatto, che avvenne nel tempo giusto. Si accomodò sulla mia pancia e mi suggerì di fare la cosa giusta mentre nell’appartamento accanto la tromba di un quartetto jazz suonava un lento assolo malinconico e sin troppo banale, data la nostra situazione: due che fanno l’amore in un tardo pomeriggio piovoso. Ma era comunque musica. Valeria si mosse con tutta la sua poca ma dura carne dicendo “ va bene va bene “ per rassicurarsi forse, oppure per ratificare un avvenuto possesso. Toccavo con i palmi la sua pancia calda. Lei sorrideva con i suoi sul mio petto, per frenare ogni dolore e per dirmi che ormai era lì.
Alla fine pronunciò il mio nome, con una voce curiosamente neutra, come se mettesse la firma su un atto, sul godimento realizzato, sull’imprevedibile entrato a far parte del regno dei fatti.
Ci tenemmo stretti, mischiando i fiati e gli umori, ormai anche sotto un tetto e al caldo potevamo non parlare, sapendo bene che avremmo ricominciato quando fosse finito il deflusso della corrente emotiva che segue lo strano esperimento del sesso, questa cosa così comune e così inesplicabile. L’acqua faceva tintinnare il vetro; una persiana della porta-finestra del soggiorno si era sganciata, batteva contro il muro e poi tornava a chiudersi. Mi alzai e rapidamente la riagganciai. Rimettendomi a letto dissi piano: “E’ il secondo diluvio universale. Durerà quaranta giorni. Ti dispiace?“
“Al contrario. Ho pregato perché arrivasse. Mi dicevo: se il Messia non vuole farsi vivo, allora che venga il diluvio “.
La musica dopo una pausa aveva ripreso con una prevalenza di sax soprano, che mi parve di riconoscere. Per fare il disinvolto provai a fischiettare il tema seguendo il ritorno dei musicisti, ma lo faci male, stonando e sfiatando miseramente. Quando il cellulare emise la sua ripetuta nota acuta, Valeria allentò un po’ la presa del braccio intorno al mio fianco ma non si mosse.
Andai in cucina a preparare un tè, e lei in bagno a fare la doccia. Quando tornò aveva il mio accappatoio e i capelli bagnati; disse che non era riuscita a trovare il phon.
“Per caso sai dov’ è?“
“No, ma sono sicuro che signora Filoramo qui accanto ne ha uno che sarà felice di prestarti“. Valeria rise e si sedette al tavolo. Prese la tazza con tutte e due le mani e ci soffiò sopra. La guardai e dissi: “ Direi che faresti meglio a usare il phon“.
Sulla porta mi diede un bacio lungo, tenendomi una mano sulla nuca, mentre infilava l’altra sotto il polsino della camicia muovendo piano le dita sul rilievo delle vene. Quando si staccò la ripresi e lei fece finta di volersi liberare per poi rioffrirmi il viso e la bocca aperta che sapeva di tè. Il corpo ora vibrava; era sempre lo stesso strumento ma era cambiata l’accordatura, che adesso era più intonata e più profonda. Era spiovuto, e quando uscì dal portone la guardai che attraversava la strada e a piccoli passi andava all’angolo opposto, dove aveva lasciato la macchina. Immaginò che la stessi guardando e si voltò per farmi un saluto con la mano, la stessa mano con cui mi salutava sempre e che mi inteneriva.
Nemmeno stavolta ci eravamo scambiati i numeri di telefono. Io aspettavo che fosse lei a darmelo, e forse lo stesso faceva lei. Così dopo qualche ora, steso sul divano con un libro cominciò a montarmi la paura che potesse di nuovo sparire. Il sospetto divenne certezza la mattina. Andavo nervosamente su e giù sotto la pensilina della fermata; avevo deciso di prendere l’autobus per far prima, ma più i minuti passavano più mi convincevo di aver fatto la scelta sbagliata: se fossi andato a piedi sarei stato già a metà del percorso, ma a quel punto non potevo fare altro che aspettare.
La trovai seduta al tavolo d’angolo. Stava bevendo un cappuccino e un po’ di schiuma le aveva macchiato la punta del naso. Gliela tolsi con l’indice e lei sorrise, un po’ arrossendo. “Quante ore, oggi, professore ?“
“Solo tre. Oggi mi accontento di tre. Sai, è meglio non esagerare con la filosofia. I ragazzi fingono di apprezzare le speculazioni degli antichi ma la verità è che non capiscono tutto questo accanimento e si annoiano“.
“Io mi annoiavo e basta. Ma capivo. Se togli il troppo che c’è, la filosofia può anche avere una sua utilità pratica, no?“
“Questo dell’utilità o della non utilità è per l’appunto un problema filosofico“.
“Bene, devo andare, ma ci penserò su“.
“Quando ci vediamo?“
“Non lo so. Forse il prossimo fine settimana… “.
“Perché forse?“.
“Puoi immaginarlo. Il perché è quello che puoi immaginare senza sforzo“. Era la prima volta che le sentivo quel tono aspro, che non le somigliava. Non volevo essere da meno. Dissi d’un fiato e guardando ostentatamente da un’altra parte:
“Lo immagino così come immagino, anzi sento, che avrò voglia di vederti“.
La discussione stava prendendo una piega spiacevole. Capivo le sua ragioni ma lo stesso non potevo fare a meno di irritarmi. Tornava a visitarmi quel sentimento di torto subito, e ancora una volta puntavo i piedi, anche con più forza dato che, non saprei dire sulla base di quale rito di appropriazione, ora sentivo di averne diritto. Lei ora era in piedi, con la borsa in mano e l’impermeabile azzurro tra il braccio e il fianco. A quel punto si era avvicinato Giorgio. Si sedette nella sedia libera e mi chiese: “Cosa prendi, Vittorio?“ Risposi che stavo per ordinare un caffè ristretto; poi dissi: “La mia amica Valeria“. Lei disse il “ Piacere “ di rito, fece il gesto di guardare l’orologio e dicendo che era terribilmente in ritardo uscì quasi correndo dal locale.
Seguirono giorni instabili, mutevoli, troppo silenziosi o troppo pieni di parole. Alternavo euforie e scoraggiamenti, desiderio e rabbia. A scuola ero irritabile, spiegavo male, senza riuscire a suscitare interesse nei ragazzi che mi ascoltavano attenti come sempre ma di certo non riuscendo a capire cosa mai mi fosse successo di tanto spiacevole se così d’improvviso non ero più l’insegnante disponibile e coinvolgente che ero sempre stato. Se uno mi interrompeva per chiedermi un maggiore approfondimento su un punto particolarmente difficile, o mi chiedeva di fare un collegamento tra due autori, rispondevo di malagrazia appellandomi al poco tempo che avevamo a disposizione per dare fondo all’intero programma ministeriale.
Tornato a casa me ne vergognavo e giuravo a me stesso che non sarebbe più successo, che era mio dovere dare agli alunni tutte le spiegazioni che mi richiedevano. Ma l’indomani il mio atteggiamento non cambiava. Ero sempre più distratto, parlando non mi riusciva di star fermo, non vedevo l’ora di finire per tornarmene ai fatti miei.
Valeria compariva la mattina, beveva il suo cappuccino accarezzandomi le mani e poi scappava in ufficio, frenetica, nervosa, dicendo ogni tanto “ ti voglio anch’io, lo sai “, e se rispondevo che invece non lo sapevo mi dava un bacio e mi carezzava il petto. “ Verrai quando ne avrai voglia “ le dicevo. Lei sorrideva e andava via salutandomi con la mano. Ma il mio desiderio cresceva, non facevo che ripensare al caldo delle sue gambe e alla sua faccia mentre si muoveva a brevi scosse e poi si piegava aprendo la bocca perché da lei prendessi il fiato che mi mancava.
Un giorno, a pranzo dalle parti del teatro Verdi, feci quello che non pensavo di poter fare: la raggiunsi in bagno e lì cercai di penetrarla tenendola seduta sul bordo del lavandino. Lei svelta capì che il modo migliore era un altro e fu perfetta e dolce e quando tutto finì mi disse che non avevo pazienza e non capivo.
Poi si mise a piangere silenziosamente e io vedendo nello specchio la mia faccia arrossata e i capelli scomposti provai vergogna per come non capivo quella donna insicura che forse voleva lasciarsi andare ma sentiva di non poterlo fare. Prima di uscire strappò un pezzo di carta igienica e con una matita ci scrisse il suo numero di telefono.
Con quel pezzo di carta stretto nel pugno tornai al tavolo dove lei si era già seduta. Valeria si mise a raccontarmi di una confusione all’ufficio e di come aveva temuto di avere fatto un errore madornale, uno scambio di file che aveva messo in imbarazzo il responsabile della sua sezione. Per fortuna l’equivoco era stato scoperto in tempo; il responsabile, un certo Federico, aveva chiesto di poter fare una pausa e si era fatto mandare il file giusto. Federico era stato comprensivo con Valeria e lei lo aveva ringraziato regalandogli una cravatta.
Le dissi che ero geloso e che volevo anch’io una cravatta, anzi ne volevo due, e più belle di quella che aveva comprato per Federico. “ Tu non te la sei meritata “ rispose ridendo
“La mia fortuna è che non porto la cravatta“.
“La tua fortuna è che io sono una persona buona e ti comprerò lo stesso una bella cravatta che metterai la prossima volta che mi porterai a cena fuori“ replicò lei, che non si faceva mai trovare a corto di risposte.
Ora che avevo il suo numero mi sentivo forte, sicuro, ripreso nel mio solito ritmo. Pensavo, ingenuamente, che bastasse un numero di telefono per scongiurare il pericolo di una sua sempre possibile sparizione.
Nonostante le lacrime, il problema della sua situazione personale – il marito, il figlio – non sfiorava neppure la mia coscienza. Per me contava solo poterla avere ogni volta che ne avevo voglia; godere della sua compagnia ogni volta che ne sentivo il desiderio. Al futuro non avevo nessuna voglia di pensare. Dopo Barbara sapevo quanto fosse precario e incerto, come tutto può cambiare da un momento all’altro.
Spesso di sera facevo lunghe camminate in centro. Guardato le vetrine dei negozi, prendevo una grappa in un bar e poi finivo a girare per gli scaffali di una o due librerie. In una di queste librerie avevo conosciuto Valeria. Stavo curiosando nel reparto di libri per l’infanzia e una bambino di cinque o sei anni con un libro illustrato tra le meni era venuto a sbattere contro le mie gambe; poi, come se nulla fosse, aveva alzato il libro e aveva detto: “ Ti piace? “ Io avevo preso il libro, mi ero inginocchiato e avevo preso sfogliarlo insieme a lui. La madre, che lo aveva perso di vista e lo chiamava con nella voce il tipico allarme delle madri che si sono persi i figli e stanno già immaginando il peggio, ci vide e si avvicinò. “ Ecco dove ti trovo “ disse, “ impegnato a dar fastidio alla gente “. Dissi che non mi aveva dato nessun fastidio e mi presentai. Finì che andammo tutti in pasticceria. Poi, una decina di giorni dopo, ci incrociammo in via Libertà e passammo due ore a parlare di tutto, ma soprattutto di cinema.
La sera mi preparavo una cena fredda e facevo il giro dei canali; se c’era qualcosa di passabile mi fermavo, sennò spegnevo e mettevo un p0’ di musica. A mezzanotte, come cenerentola, mi mettevo a letto e fino all’una circa leggevo; in quei giorni il libro era La ragazza di Bube, ed è fin troppo ovvio che la protagonista Mara mi facesse pensare a Valeria. Valeria, pensavo, è una Mara che ha studiato. Se non avesse studiato sarebbe esattamente come Mara. Prima di spegnere l’abat-jour le mandavo un messaggio, e a volte la frase che le mandavo era una citazione del romanzo, altre volte, e più spesso, cercavo di formulare un pensiero affettuoso che non fosse troppo banale. Non sempre ci riuscivo, spesso cadevo nell’errore opposto, l’aridità, la mancanza di sentimento. Valeria ironica me lo faceva notare e rispondeva: “ Lasciati andare, giuro che la cosa rimarrà tra te e me “.
Si avanzava dentro dicembre a passi che a me sembravano regolari e tranquilli, soprattutto ora che Valeria non mi dava pensieri, che pareva decisa a non sparire. Vedersi era difficile, ma lei aveva una speciale abilità nell’organizzarsi. Il marito era spesso fuori per lavoro, col bambino restava una ragazza sperimentata che le toglieva ogni ansia. Quando avevamo più tempo facevamo l’amore e poi andavamo al cinema, e dopo il cinema cenavamo in un ristorante indiano del Borgo. Una sera mi portò un pacchetto col fiocco rosso, e dentro c’erano tre cravatte due a pois e una a righe. Io per lo più le regalavo profumi e foulard, e una volta un libro di un fotografo francese. Dentro c’era il ritratto di una ragazza che le somigliava. Glielo feci notare e lei disse: “ Ma questa è Isabelle Huppert , l’attrice! “ e fece risuonare la risata scoppiettante che per me era un’ora in più di buona salute.
Per le feste tutta la famiglia partì per il Nord. Il marito era di Torino e le vacanze, quando non andavano all’estero, le passavano dai parenti di lui. Per me le feste sono sempre piuttosto tristi. Non ho più nessuno e l’unico zio che mi è rimasto, fratello di mia madre, vive in Francia. Ogni tanto mi telefona per invitarmi, mi dice che il Natale lassù da loro è davvero bello, insistono, ma io dico sempre che per quell’anno no, ma che il prossimo di sicuro andrò a trovarlo, e finirà che davvero dovrò farlo questo viaggio, zio Alfredo se lo merita, la moglie è morta tre anni fa e anche lui come me è rimasto solo.
Non vedevo l’ora che le feste finissero. Non vedevo l’ora di rivedere Valeria, di risentire il suo odore e ascoltare la sua voce. Era passata la prima settimana di scuola e non l’avevo ancora vista. Dopo un paio di messaggi senza risposta, la chiamai. Il telefono suonava ma lei non rispondeva. Riprovai e stavolta rispose una voce di donna che mi comunicava che il numero era spento o irrangiungibile. Mai come quella volta compresi il significato della parola irrangiungibile . Mi resi conto che questo significato aveva a che fare con la perdita del senso dell’orientamento. Ebbi la certezza che irrangiungibile voleva dire “tu sei solo e gli altri invece no“; voleva dire l’interminabile attesa dietro la porta che nessuno ti aprirà.
Ma non per questo smisi di bussare. Facevo il suo numero almeno trenta volte al giorno, sperando di coglierla di sorpresa, di insinuarmi nell’interstizio lasciato incustodito dalla sua ferrea volontà di non rivolgermi la parola o rispondere ai prolissi o disperatamente laconici messaggi che le inviavo.
Telefonare e scrivere messaggi era diventata l’occupazione principale delle mie giornate. Le lezioni erano semplicemente una fastidiosa parentesi tra due ostinate e interminabili serie di chiamate e di digitazioni. Non sapevo più cosa scrivere ma scrivevo, avendo cura di non ripetermi, come se le mie possibilità aumentassero con la proprietà di linguaggio e la varietà retorica e le citazioni letterarie che non sapevo più dove andare a scovare.
Il desiderio mi toglieva l’appetito. La rabbia impotente me lo faceva tornare. Ma tra fame beona e inappetenza finii per ammalarmi. Di organico, disse il medico, non avevo niente, solo un piccolo esaurimento, forse dovuto a un eccesso di impegno lavorativo. Per dieci giorni non andai a scuola. E così ero libero di dedicarmi alle chiamate e al resto. Il resto erano i lunghi piantonamenti della zona antistante il luogo dove lavorava Valeria, più le visite a sorpresa nei bar e nelle trattorie del quartiere.
Ero diventato matto? E’ possibile. E se non lo ero ancora diventato, ero a un passo dal diventarlo. Quella trentenne tutta ossa, le mani da bambina e gli occhi sempre pronti a stupirsi giocava con i miei nervi come un’arpista con le corde.
Poi una sera, sul tardi (saranno state le undici- undici e mezza) mentre mi rigiravo nel letto cercando di prendere sonno, il cellulare si mise a suonare. Era lei. Disse che aveva bisogno di vedermi. Dieci minuti dopo era seduta in soggiorno. Portava un dolcevita nero, jeans e un anello nuovo all’indice della mano sinistra. Sembrava oro bianco. Ma forse era un metallo meno nobile L’anello rifletteva la luce del lampadario e il suo dito era tagliato in due da una fiamma. La pelle del viso era tesa; una breve ruga allentava lo spigolo dello zigomo destro. Sta invecchiando anche lei, pensai. Tra cinque anni sarà una donna di mezz’età.
Dalla strada arrivavano il suono dei motori e quello delle raffiche di vento. Di tanto in tanto anche il pianto di un neonato.
Si era distesa sul divano e guardava i tetto con le mani intrecciate sullo stomaco. Seduto nella poltrona di fronte, con pantaloni del pigiama e un pullover a giro collo verde, cercavo di farmi venire in mente una frase d’esordio che avesse la giusta temperatura, che non tradisse la furia che mi logorava, che mi aveva logorato per tutto quel tempo. Poi smise di fissare il tetto, si alzò e andò verso lo stereo. Mise un cd e lo fece partire col volume piuttosto alto; troppo alto per i miei gusti, per come mi sentivo in quel momento, e anche per l’ora.
“ Abbassa quel volume, per favore “. Lei non sentì, o finse di non sentire. Lo dissi di nuovo, più forte. Valeria si girò, si avvicinò alla poltrona e disse: “ Cos’è, non ti piace la musica? devo cambiare disco? “
“La musica va bene, ma il volume è troppo alto“.
“La voglio sentire a questo volume, se non ti dispiace“.
“Mi pare d’avertelo detto“.
“Non sei gentile “.
”Sono gentile. Stai ascoltando la musica quando invece non dovresti nemmeno essere qua“.
“E dove dovrei essere, secondo te?“
“Non lo so. Dimmelo tu“.
Non rispose. Si inginocchiò e con la mano, quella con il nuovo anello, mi tocco in mezzo alle gambe. Le dissi di smetterla ma lei si stava arrampicando sulla poltrona, con movimenti da gatta scheletrica. Aveva l’alito che sapeva di vino. Le mani fredde. Il collo del maglione sapeva di fumo di sigaretta. Nell’attimo in cui la colpii, mi resi conto che era l’unica cosa sensata che potessi fare. Si allontanò di scatto, ma qualcosa nella sua strana calma mi fece pensare che se l’aspettava, che forse era quello che andava cercando.
Il bambino aveva ripreso a urlare, a piangere, me l’immaginai dentro la culla che si dibatteva per un desiderio o un malanno che non era in grado di esprimere. Come noi. Come me. La musica era finita. Si rifece sentire il vento e un gorgoglio familiare nella notturna segretezza dei tubi dell’acqua.
Si era seduta per terra con le spalle appoggiate al divano. Ora mi guardava con gli occhi lucidi, grandi ma senza nemmeno l’ombra dello stupore infantile che conoscevo. Disse: “Sei dimagrito“. Dissi che lo sapevo e che non me ne importava niente, tanto avevo bisogno di eliminare qualche chilo e che forse dovevo ringraziarla per essere stata un’efficace cura dimagrante.
“Allora è vero che c’è un lato positivo in tutte le cose“.
“Forse. Il guaio è che quello negativo è molto più pesante“.
“Cosa devo fare“ disse con un tono monocorde che annullava la domanda.
“Facciamo che torniamo al cinema“.
“Puoi andarci da solo“.
“Meglio con te“.
“ Solo meglio “.
“Molto meglio“.
“ Quanto misura ‘molto meglio’, Vittorio? “
“Allora misuralo, e fammelo sapere“.
Mi alzai e dissi che andavo a letto. Lei non disse nulla, rimase dov’era, immobile, un piccolo animale stanco che aspetta l’arrivo di un altro giorno. Poco dopo la sua ombra si avvicinò al letto. Un fiato tiepido lasciava tracce di saliva sul mio stomaco e scendeva piano, senza fretta, come se avesse davanti un tempo inesauribile. Una ragazzina che lavora con puntiglio all’edificazione del suo castello di sabbia.
La lasciai fare, e quando finì mi addormentai.
Il giorno dopo la città si svegliò sotto la neve. Non tanta, ma per una città meridionale era un piccolo avvenimento. In lontananza, le cime delle brevi montagne rilucevano allegramente; sul tetto delle auto in sosta lo strato di neve faceva pensare al velluto bianco.
L’aria metteva in rilievo i suoni, il freddo spingeva l’andatura dei passanti. Il vapore dei fiati si librava a mezz’aria. Era l’ultima domenica di gennaio, cinque giorni dopo avrei compiuto cinquant’anni; nessuno se ne sarebbe ricordato.
La mattina del quattro marzo un telegramma mi comunicava la morte del vecchio Alfredo, e l’indomani presi un aereo per partecipare al funerale. C’era poca gente, faceva molto freddo. Mi fermai tre giorni e visitai un po’ la città. Marsiglia è affascinante, soprattutto il quartiere vecchio e la zona del porto. Nelle osterie si mangia bene.
Valeria non l’ho più vista. La settimana scorsa ho saputo che se ne sono andati, non so dove; il marito ha chiesto il trasferimento e l’hanno accontentato. Pare che fosse uno dei migliori e non potevano dirgli di no. Bravo a snellire le aziende, secondo la formula usuale. Ogni tanto mi capita di trovare qualche traccia di Valeria; le ha lasciate nei posti più improbabili, e non so dire se con intenzione o per beata distrazione.
Sono oggetti insignificanti: un pettine, un nastro di seta per fermare i capelli, una scatoletta di cartone rigido per conservare anelli e collane, o spille. Ogni volta che ne trovo uno penso un po’ a lei. Spero che non le manchi mai l’acqua.











